intervista a Gerhard Roth
di Lorenzo Pieraccini
- La prima domanda che vorrei porle concerne il suo studio di neuroscienziato. Quanto contano oggi le conoscenze neuroscientifiche nello studio della mente?
Roth: ritengo che non si possa fare una teoria della mente senza tutti i dati della neurobiologia, in quanto le speculazioni possono andare in qualsiasi direzione, ma spesso le verità sono controintuitive.
Le caratteristiche dell'avere un'esperienza personale, del modo in cui pensiamo e di come percepiamo il mondo, non sono identiche a quelle dei processi cerebrali che hanno luogo nel cervello. Noi non percepiremo mai i meccanismi di sincronizzazione o l'attività diffusa, la topologia, della corteccia perché la nostra esperienza personale è illusoria in questo senso. È parte del senso comune pensare che ci sia un'istanza che pensa, che ragiona, che ha una certa percezione, ma poi studiando il cervello ci si rende conto che queste attività sono tutte in parallelo e distribuite. L'attività neuronale ha una forma molto diverso rispetto all'attività cosciente delle sensazione che noi sperimentiamo, tale esperienza è infatti un'illusione creata dal nostro cervello.
- L'esistenza della mente come la conosciamo attraverso l'introspezione è dunque fallace. Ma allora perché parliamo di mente e non solo di processi neuronali quando cerchiamo di spiegare l'attività cosciente umana?
Roth: da una parte si può dimostrare che quando abbiamo certi pensieri, certi sentimenti, c'è sempre un relativo substrato neuronale nel cervello. È possibile che un certo pensiero sia rappresentato da diversi processi neurobiologici, ma c'è necessariamente un rapporto tra stato mentale e stato cerebrale. Se si studiasse per lungo tempo un cervello di un individuo, alla fine, si potrebbe indovinare quello che pensa e quello che vede. Se lo si facesse bene si noterebbe che per ogni sensazione, ogni pensiero, ogni percezione e ogni emozione esiste un determinato substrato neurobiologico definito. Quindi si potrebbe identificare l'attività neurobiologica con l'attività mentale. Dall'altra parte però dal solo studio del cervello e della sua attività non si può capire, dall'aspetto neurobiologico e dal comportamento delle cellule, il significato, il “ meaning” di tale attività, che può essere determinato solamente dopo esperimenti psicologici, per esempio chiedendo ad una persona cosa pensava o cosa provava durante gli esami neurobiologici.
Dalla sola attività della corteccia, non si può determinare ciò che quella attività significa, tale significato non è per niente evidente. Se invece si domanda al paziente: hai visto qualcosa? Ed egli risponde per esempio: “sì, una freccia rossa”, a quel punto registrando l'attività della corteccia si può affermare che quei determinati processi sono l'equivalente di “vedere una freccia rossa”, ma dall'attività neurobiologica soltanto non si può dedurre niente. Soprattutto si deve considerare che quello che è il substrato della coscienza e della percezione, nella mente, non è determinato soltanto dall'attività che si può misurare, è molto di più. Si possono misurare poche cose dell'attività delle sinapsi.
In realtà c'è molto di più. Quindi non si può sostenere che un pensiero non sia nient'altro che il “firing” di una certa popolazione neuronale, perché ciò non è vero; è molto più complicato e dobbiamo ammettere solamente che quando i neuroni interagiscono in un certo modo emerge la coscienza o un pensiero ed il rapporto è sempre di uno ad uno: uno stato mentale implica uno stato neuronale, ma non si può ridurre l'esperienza all'attività neurobiologica.
- Per quanto riguarda la coscienza lei dice che il cervello produce la coscienza e fornisce le prove delle basi neurofisiologiche di questa produzione. Si può dire che questo spieghi la coscienza?
Roth: In un certo senso sì. Nei miei ultimi libri ho riformulato il concetto di coscienza fino ad arrivare a considerare almeno dieci tipi diversi di coscienza e si può mostrare come tutte queste coscienze abbiano un sostrato definibile nel cervello. D'altra parte però si può anche spiegare perché abbiamo bisogno della coscienza. Per esempio senza la coscienza non sarebbe possibile rendersi conto di ciò che si vede e si legge. In oltre anche la verbalizzazione è basata sulla coscienza. Possiamo avere percezioni non coscienti ma non possiamo darne conto in un atto verbale. Non possiamo effettuare alcun “report”. Ogni atto verbale prevede coscienza. Essa è dunque una forma di “information porcessinig”. Si può perciò spiegare la funzione della coscienza nell'ambito delle leggi naturali e dell'information processing. Non c'è un aspetto mistico in essa, anche se nessuno può esattamente spiegare come funziona. Forse in futuro ciò potrà avvenire...
- Che rapporto esiste invece tra processi consci ed inconsci? Cosa possiamo conoscere della nostra mente e cosa ci rimane inaccessibile?
Roth: questo è un problema di sviluppo individuale. I centri che producono l'Es (i processi inconsci)
si sviluppano molto prima dei centri che producono la coscienza, i quali si basano sull'attività della corteccia. Tutto quello che un neonato percepisce è o inconscio o comunque non può essere ricordato, non può essere memorizzato a livello cosciente. Forse il neonato può sviluppare prima dei tre anni processi consci, ma non può ricordare tali processi, perché la memoria non è ancora completamente sviluppata.
In oltre l'attività dell'amigdala e del sistema limbico è inconscia. Questi sistemi, del resto, si sviluppano molto prima e poi dominano il nostro comportamento decisamente più che i processi consci, che si sviluppano più tardi e non hanno poi grande influsso sul nostro comportamento rispetto a quegli inconsci; infatti il 90 per cento di ciò che facciamo è basato su processi inconsci.
C'è anche un altro punto importante: molte cose che un tempo erano coscienti (erano state apprese attraverso processi consci) ora non lo sono più sono pre-coscienti, intuitive.
Il 70 percento dei processi mentali sono “fuori dalla corteccia”, inconsci, prodotti dal sistema limbico. In oltre nella memoria a lungo termine si trovano tracce delle cose che una volta abbiamo imparato coscientemente ma che ora sono “sommerse”, sono diventate intuitive, automatizzate.
Tutto ciò è importante poiché questi processi guidano il nostro comportamento senza che ce ne
rendiamo conto. Pochissima parte del nostro comportamento viene regolato dalla ragione cosciente, poco, pochissimo, l'un per cento.
Questa è perciò la relazione che esiste tra pre-cosciente, incosciente, intuitivo e la coscienza acuta: tre anni fa ero a Siena e ho fatto tante cose, ho parlato con alcune persone e ho visto determinate cose, queste esperienze però non sono più presenti in dettaglio. Solamente quando sono di nuovo a Siena questa memoria inconscia(delle esperienze già vissute) si riattiva, mi guida, anche se non mi posso rendere conto (non posso accedere in prima persona) che cosa sia che mi guida. Ero con il professor Nannini in un ristorante e ho mangiato qualcosa che mi ha fatto stare male, sono quasi morto. Adesso solo questo ricordo è presente coscientemente, tutto il resto (delle esperienze) mi guida ma non è presente coscientemente, almeno non in modalità attenzionale (non posso rendermi conto che tali esperienze mi guidano).
- Ultimamente stanno emergendo sempre più conoscenze sui processi del cervello. Molte scoperte portano ad ammettere che l'io non esista e che sia un'illusione, lei cosa ne pensa?
Roth: Sì, io ho molto lavorato, negli ultimi tempi, con psicologi dello sviluppo dell'infanzia e insieme abbiamo verificato come si possa dimostrare l'esistenza di diverse fasi dello sviluppo dell'io del bambino. Ad esempio una forma di io estremamente primitiva è quella che permette al bambino di riconoscere i propri bisogni. Sviluppatasi questa capacità si evolve l'io dell'identificazione di sérispetto alla madre, poi l'io come agente, cioè la padronanza dei propri movimenti; l'io sociale e l'io linguistico si sviluppano più lentamente. Si può dimostrare che l'evoluzione di queste forme di io parallela a quella del cervello.
L'io però è sempre un “label”, un attributo, non un meccanismo. Per esempio quando un bambino fa qualcosa e sente la madre dire frasi del tipo: “Tu sei stato bravo”. Prima deve imparare che quando la madre afferma: “io ti dico che tu...” si riferisce a se stessa, poi deve capire che il “tu” è lui stesso.
Questo avviene in un certo periodo dopo il quale il bambino capisce che il “tu” è lui e allora capisce (apprende il concetto) anche che tutto quello che è controllato dal suo corpo e dalla sua mente è il suo “Io”. In realtà però l'io non è una sostanza che controlla tutto, è un “label” un'istanza unificatrice.
Allora si può dire che da una parte l'io è un'illusione: l'illusione che l'io stia al di sopra di tutti gli
altri processi mentali e li controlli. Dall'altra parte però senza la costruzione dell'io gli uomini non
potrebbero agire. Per esempio pazienti che hanno perso l'istanza unificatrice dell'io non sono in
grado di agire nel mondo.
La mia posizione è che da una parte l'io è una costruzione del cervello che non esiste di per sé,
come sostanza, ma allo stesso tempo senza questo principio compositivo l'uomo non potrebbe agire.
Allo stesso modo nella società umana esistono delle costruzioni, come la dignità dell'uomo, che non hanno una realtà fisica, ma sono concetti molto importanti. Concetti illusori possono essere molto importanti, democrazia per esempio!
- Nel cervello si può riscontrare una regione che può essere considerata la sede dell'Io?
Roth: di io differenti! Esiste, per esempio, una regione della corteccia prefrontale chiamata pre- SMA (Supplementary Motor Area) che si attiva solamente quanto agiamo in conformità con la nostre motivazioni interne. Tale area si attiva solamente nel caso in cui sentiamo che la nostra azione è guidata da un bisogno spontaneo ed interno al corpo e non ci sono motivazioni imposte dall'ambiente esterno. Si deve notare che se in un paziente si stimola elettricamente questa regione egli inizia un'azione e afferma di averlo fatto per sua volontà. È evidente invece che è stata la stimolazione elettrica a determinare tale azione.
È molto complicato capire il circuito neuronale che determina i motivi che ci spingono, per esempio, ad alzare un braccio. O tali motivazioni vengono da fuori, come nel caso del comando: “alza il braccio”, o vengono da dall'interno del corpo. Solo quando mi rendo conto che tali motivazioni provengono dal mio corpo, da me stesso quindi, posso sviluppare il concetto di “io agente”. Mi rendo conto cioè che sono il fautore dei miei atti.
Questo è solo un esempio di come l'io emerga dal cervello, ma ci sono molti altri tipi di io: della percezione, del linguaggio e della memoria, per citarne alcuni, e tutti questi tipi di io, quando ne diventiamo coscienti, posseggono diverse localizzazioni nella corteccia. Si può dimostrare subito, ad esempio, come a causa di una lesione del cervello il senso dell'io come agentività possa scomparire mentre senza che ciò disturbi la percezione e la capacità intellettiva; pazienti con tale lesione hanno l'illusione che qualche forza esterna li guidi.
Un altro esempio può essere fornito studiando la capacità di riconoscersi allo specchio. Può succedere che alcuni pazienti si alzino la mattina e vedano nello specchio, al posto di loro stessi, una persona che non conoscono. Questo accade perché i centri parietali che sono addetti al riconoscimento del viso solo lesionati o distrutti e non si può riconoscere nessuno, nemmeno se stessi. Dall'altra parte, pur non riconoscendosi nello specchio, il resto del loro io è sano e quando fanno qualcosa affermano tranquillamente“sono io che lo faccio”, ma non riescono a riconoscersi nello specchio. Allora si può intuire come i diversi io siano distribuiti nella corteccia quando sono coscienti, altrimenti se ci fosse un solo centro dell'io ci sarebbe un tutto o nulla; o l'io c'è o l'io non c'è. Invece come ho mostrato può darsi che alcune forme di io sussistano anche se altre sono sparite, questo perché la loro distribuzione nella corteccia è altamente differenziata.
- Un altro annoso problema con il quale oggi le neuroscienze si confrontano è quello del libero arbitrio. È un problema ancora più grande di quello dell'Io perché tutte le persone si sentono libere...
Roth: Non tutte! Ci sono pazienti che affermano: “io non sono libero, una forza dentro di me mi
dice quello che devo fare, io non sono libero”. Si potrebbe anche citare chi soffre di impulsi ossessivi: egli è costretto a fare qualcosa, come lavarsi le mani ogni cinque minuti, lo deve fare!
Ne è obbligato a causa di una malattia che attacca i gangli basali. Il suo cervello lo obbliga ad agire senza che egli possa compiere una scelta libera.
Quando abbiamo molta sete, in ogni caso, dobbiamo bere, non siamo liberi, può succedere che si beva anche se l'acqua è sporca e non ci sentiamo liberi, siamo spinti da un bisogno molto forte.
Perciò possiamo dire che sentirsi liberi significa: non c'è una forza esterna o interna che ci comanda, che ci domina e l'assenza di queste due forze significa “essere liberi”. Queste sono le precondizioni, questo basta. Gli psicologi che studiano le condizioni nelle quali le persone dicono “io mi sento libero...a partecipare a questo convegno o a bere o a non bere un caffè, ecc.” assumono semplicemente che essi siano liberi se nessuno li costringe e potrebbero agire altrimenti. Se ad esempio ho davanti del tè e del caffè, la libera scelta, io scelgo il tè invece del caffè e mi sento libero. Se tu mi domandi chi ha deciso per il tè invece che per il caffè, io affermo:io! Sentirsi liberi basta per la gente. In realtà studiando il cervello umano si potrebbe determinare esattamente quali siamo i processi cerebrali che hanno spinto a prendere il tè invece del caffè. Si possono spiegare i motivi totalmente. Allora io mi sento libero quando ho una scelta, ma questa scelta è determinata dai miei geni, dall'esperienza infantile, dalle esperienze fino ad oggi e tutti questi motivi mi determinano in continuazione.
Se si studiano a livello neurologico e psicologico le persone che bevono indifferentemente caffè o
tè, non si potrà dire preventivamente se prenderanno uno o l'altro. Infatti quando i motivi per effettuare una scelta si equivalgono, non ne esistono di prevalenti, può darsi che per scegliere si sia costretti addirittura a ricorrere al dado, al caso. Questo significa che a volte i meccanismi del cervello non trovano una motivazione forte per una soluzione o per l'altra. Non sempre quindi il nostro cervello determina esattamente le nostre scelte.
Hume affermava: “siamo liberi, ci sentiamo liberi, quando abbiamo una scelta”.
Quando decidiamo qualcosa, questo evento è sempre determinato dalla nostra personalità. Bisogna rendersi conto che la possibilità di decidere, la possibilità kantiana di decidere senza pulsioni, è assurda, non esiste. Quando Kant scriveva parlava principalmente della moralità. La moralità è agire contro i propri interessi, contro le proprie motivazioni interne. Per esempio se vedo qualcosa di molto attraente e nessuno mi guarda potrei volerlo rubare, ma non lo faccio per senso morale.
Anche aiutare un amico, o la propria moglie non è morale, perché dettato dal sentimento. La moralità è la coscienza della moralità. La moralità ha ragione in se stessa diceva Kant, ma questo è assurdo!
La gente ruba quando le probabilità di non essere presa sono minime; poche persone lo fanno anche rischiando. La ragione, quindi, entra in gioco solamente per calcolare le probabilità di successo, l'essere morale invece deriva dall'educazione ricevuta. La moralità è basata sull'esperienza individuale e sociale. Io, per esempio, sono stato educato da mio padre e dalla mia famiglia a non rubare anche se nessuno se ne accorge. Perché diventi un sentimento morale, però, un precetto deve essere ripetuto molte volte. È educazione.
La libertà morale di Kant non esiste: la moralità è educazione.
Per esempio, se accade che ti facciano molto arrabbiare e tu non uccida chi ti ha offeso significa che hai imparato a controllare i tuoi impulsi, che quella è diventata la tua natura, oppure che il tuo cervello ti ha allertato che ti possano prendere e mettere in prigione. Se però perdi veramente il controllo e uccidi, in tribunale il giudice ti condanna: “tu avevi la possibilità di resistere alla tentazione, e non l'hai fatto, sei responsabile delle tue azioni” dirà. In realtà tu potresti sostenere che ciò non era sotto il tuo controllo. Non sei responsabile dei tuoi geni e della personalità che ti hanno portato a fare quel gesto. Questo è un grosso problema etico che non si può risolvere in quanto il nostro diritto penale è basato sull'idea della libera volontà, che non esiste. O tu resisti perché hai una certa educazione e certi geni o non resisti perché hai un'altra educazione.
Noi studiamo i giovani criminale e investighiamo i motivi per cui commettono dei reati e possiamo sostenere che il 20, 30 per cento del loro comportamento è influenzato dai geni e il resto dall'educazione, della famiglia in primis. Essi non sono mai liberi in quanto questo tipo di
determinazione avviene nei primi anni di vita, quando non siamo ancora coscienti a pieno. Poi ci
condiziona per tutta la vita.
Il settanta-ottanta per cento della nostra personalità si forma durante l'infanzia. Molti studi
dimostrano che nello sviluppo della personalità e del comportamento i geni hanno un'incidenza del 20/30 per cento; almeno 50 per cento viene dall'esperienza primaria, da neonato fino a tre anni, poi il restante 20 per cento è determinato dall'esperienza da adolescente e da adulto. Questo vale per tutti, per persone normali, ma anche per criminali e pazienti. Noi cresciamo con una personalità che si forma molto presto, di cui non abbiamo nessuna coscienza. Dobbiamo ammettere l'idea di essere controllati da forze che non riconosciamo. Ognuno ha la sua personalità, ma non abbiamo nessun idea da dove venga tale forma. Solo dopo uno studia approfondito di molti anni si può determinare se un tratto della personalità venga dai geni o dalla prima infanzia e così si può ricostruire l'intera personalità. Ed è quello che facciamo con i giovani criminali. Sono soprattutto tecniche psicologiche quelle che usiamo, anche studi del cervello, ma soprattutto tecniche psicologiche.
Facciamo interviste, facciamo indagini sulla famiglia. Assenza di padre, madre drogata, mancanza
di soldi, niente educazione, miseria. Da ciò si può capire come evolve la personalità di questi ragazzi, in modo quasi standard. Dire che avevano la libertà di non rubare non esiste.
- Concluso il tema del libero arbitrio, lasciandoci dietro molte domande aperte, come ogni dialogo deve fare, la vorrei interrogare su di un tema più metafisico, nel senso di riflessione sulla fisica, in questo caso sulla neurobiologia. Lei ci dice che il cervello “crea” la realtà, che ciò che percepiamo non è una semplice rappresentazione della realtà, ma una vera e propria costruzione “Bildung”. La realtà che il cervello crea è piena dei nostri ricordi, delle nostre emozioni; è un mondo fenomenico. Lei la chiama Wirklichkeit. Ce la può descrivere?
Roth: Questa è un'idea che è diventata molto comune nella neurobiologia di oggi, nessuno avrebbe qualche dubbio che è così.
Quando tu visiti un certo luogo per la prima volta tutto è nuovo, interessante. Quando ritorni nello stesso luogo una seconda o una terza volta tutto è interessante, ma non come la prima volta. Se vivi in un posto per dieci anni, poi, lo vedi completamente diverso dalla prima volta. Anche in amore è così. Tu ti innamori di una bellissima ragazza, poi se vivi con lei per dieci anni ti scordi di perché ti appariva così bella!
Quella dei sensi è sempre un'attività selettiva, ma noi vediamo il mondo sempre attraverso la nostra memoria. La memoria non riflette il mondo esterno. La stessa memoria a lungo termine riscrive sempre la nostra esperienza, ogni giorno. Essa non è una conoscenza statica, è un processo: se torni in un luogo dove sei già stato, questa percezione ti viene riformata in modo sempre diverso. Allora dobbiamo riconoscere che l'uomo vede il mondo più o meno identico, ma sempre in relazione ai dati forniti dalla memoria.
Il cervello vede quello che aspetta. All'inizio, appena nati, prima di nascere, in realtà, siamo come ciechi. Il cervello deve fare un'interpretazione di quello che vediamo una prima volta. Questo meccanismo di interpretazione che inizia con la nascita, prima della nascita e non termina che con la morte implica come suo costituente che ogni volta che si ha una nuova esperienza l'interpretazione viene attualizzata modificandone o rinforzandone certi aspetti. Ogni volta il cervello crea un nuovo mondo basato sulla nuova esperienza. È un processo totalmente interno. Se conosci una persona da dieci anni sai che non è identica a come l'hai conosciuta dieci anni prima perché nel frattempo hai vissuto un lungo periodo di tempo che ti ha riscritto tutte le esperienze che avevi memorizzato.
Il nostro grande cervello percepisce ciò che si aspetta. Noi vediamo ciò che aspettiamo basandoci sulla memoria. Spesso siamo consapevoli solo delle variazioni che un esperienza ci presenta rispetto alle caratteristiche registrate attraverso la memoria. Se questa differenza appare molto profonda il cervello riscrive e modifica il contenuto dell'esperienza, se altrimenti la differenza è minima il cervello vede ciò che si aspetta di vedere in base alle sue precedenti percezioni, e questo, a volte, è anche estremamente pericoloso. Una cosa molto comune deriva, ad esempio, dall'incontro con un amico che ha portato la barba per 10 anni e se la taglia. Quando lo vedi dopo il cambiamento o non percepisci alcuna modificazione o vedi qualcosa di vago che ti disturba, ma non riesci a capire cosa.
Non percepisci immediatamente che non ha più al barba perché il cervello ti fa percepire il mondo su per giù come se lo aspetta e ci vuole del tempo perché riscriva le nuove informazioni dando vita ad una nuova esperienza percettiva. Questo è molto pericoloso, come dicevo in precedenza, se stiamo guidando nel traffico su una strada che percorriamo costantemente da 10 anni. Può succedere di non accorgersi di eventuali nuovi cartelli che segnalano che quella strada è ora senso unico perché la nostra percezione è oscurata dall'abitudine, dalle nostre esperienze passate; è come essere ciechi!
Tutto questo avviene perché per il nostro cervello è molto pratico basare la percezione sulla memoria e riscrivere i dati in suo possesso solo in presenza di grandi differenze è un risparmio di energia!
- A questo punto devo chiederle quale sia l'illusione per cui si crede di essere in prima persona gli autore delle proprie scelte quando invece è un sistema complesso mente-cervello che ci rende ciò che siamo.
Roth: L'illusione è che ci sia un io che è padrone. Se uno accetta la propria personalità, il fatto che
si è sviluppata dai geni e dall'esperienza passata, allora si accetta il proprio essere. Allora può dire: “questo sono io”.
Io sono composto da un mosaico di tante cose. La possibilità di cambiare la propria personalità è
limitata in età adulta. Bisogna accettarsi. Siamo come siamo. Così sparisce anche l'ansia. Si deve semplicemente accettare quello che siamo. La personalità è controllata dall'inconscio, non solo freudiano. È controllata da tutto ciò di cui non ci rendiamo conto, come ad esempio le intuizioni, e dalle esperienze passate che non si ricordano coscientemente, ma alle quali si può accedere con la coscienza attraverso la memoria. Anche i pensieri sono guidati da componenti inconsci di cui non ci rendiamo conto. Ciò va accettato. Nonostante tutto esiste comunque la scelta! Solo che ogni scelta sta entro l'ambito della personalità. Per esempio, un amico ti propone di andare al cinema e tu accetti, poi ci pensi meglio e dici di no, ma non sai perché. Se finalmente viene fuori che non vuoi andare al cinema per la paura di essere circondato dalla gente, ad esempio, ne diventi consapevole, ma non sai comunque perché hai questa fobia. Nonostante la consapevolezza, rimangono celati i motivi profondi del perché le cose stanno in un certo modo e non in un altro. E questo accade spesso. Noi facciamo e diciamo delle cose di cui non sappiamo spiegare il perché. Se tu mi domandi perché vuoi restare a casa nonostante sia un film molto bello io invento qualcosa, ad esempio, che devo finire un compito, ma non è vero, in realtà, ho paura.
Spesso la gente dà spiegazioni molto complicate dei propri comportamenti perché nel profondo non sa perché agisce in quella determinata maniera e inventa, dando motivazioni superficiali. Mi accade spesso di verificare questo fatto quando parlo della mia professione con dirigenti dell'economia tedesca. Sovente tendono ad aver bisogno di esplicitare di essere in un determinato modo; hanno bisogno di riconoscersi ed affermarsi come ambiziosi e lavoratori. Potrebbe essere tutto falso, ma loro hanno bisogno di auto-rappresentarsi un quadro unitario della propria personalità. Solo se si accettano invece i fatti suddetti l'ansia di vivere sparisce; tu sei come sei.
- Il problema della personalità desta in me grande stupore. Ancora di più però c'è un punto della sua teoria che mi affascina e mi sconvolge. Esattamente quando lei dice che la differenza tra mente e cervello è una differenza all'interno del mondo fenomenico. (quindi una differenza apparente, non reale). Ci può spiegare meglio?
Roth: io da neurobiologo mi metto a spiegare come il cervello produce la mente: faccio esperimenti sul cervello. Quello che vedo dall'esperimento però è un cervello che il mio cervello ha creato. Lo vedo davanti a me, ma tu invece puoi mostrare, attraverso un altro esperimento che è la mia corteccia visiva che ha creato il cervello che sto osservando. Quello che faccio, la mia mano quando la vedo, è una costruzione del mio cervello. Tutto quello che vedo è una costruzione del mio cervello. Attraverso la fMRI posso vedere il mio cervello, ma in realtà non è il mio cervello, ma un cervello costruito dal mio cervello. Anche io sono un costrutto del mio cervello! Ogni mia esperienza è una costruzione del mio cervello. Il cervello che mi crea non esiste nella mia esperienza.
- Io: è incredibile!
Roth: Nessun neurologo avrebbe dubbio che è così. Io vedo la mia mano e domando al neurologo dove si forma l'immagine che vedo ed egli mi risponde: nel cervello. Io sento qualcosa e mi domando dove sta accadendo? Nel cervello, ovviamente! Allora la conclusione logica è che esiste un mondo esterno reale dove esistono uomini, dove esisto anche io, (un uomo chiamato con il mio nome ed un cervello): questa è la realtà (speriamo)!
Il mondo dove esisto io (come percezione di sé) è stato invece costruito da quell'uomo con quel cervello ed il mio nome, ma io non lo potrò mai vedere! Tutto quello che vedo e sento è una costruzione del cervello. Dobbiamo ammettere che c'è un mondo reale dove esistono gli uomini e gli animali con dei cervelli che costruiscono mondi attuali (fenomenici), ma per noi questo mondo attuale è il solo mondo che esiste, l'unico che possiamo conoscere e non possiamo vedere oltre.
Anche se studio il mio cervello non posso trascendere la realtà fenomenica perché ciò che vedo è costruito dal mio cervello. Io non posso oltrepassare questo mondo. Anche logicamente non è
possibile. In questo momento, mentre parliamo, due costruzioni parlano in una mente che porta il mio nome e quando tu ti percepisci discutere c'è una creatura con il tuo nome nella cui mente avviene la conversazione ed abbina ai nostri costrutti la parola Io e la parola Tu.
- Come è possibile che due costruzioni che stanno in due menti (la nostre) che sono individuali, separate, entrino in contatto. Come è possibile che si svolga una discussione tra noi se siamo ognuno nella mente dell'altro?
Roth: Nel mio libro "Bildung braucht Persönlichkeit" ho trattato questo problema di nuovo. Ancora una volta mi sono chiesto come, se ognuno è imprigionato dentro se stesso, sia possibile capirsi.
Capire l'altro è un risultato di un lungo processo. Noi ci capiamo perché siamo esseri umani. Questo significa che possiamo capire l'espressione del viso, i gesti, gli aspetti emozionali degli altri, ci sono cose che capiamo spontaneamente. C'è comprensione anche senza parole. Inoltre possiamo parlare la stessa lingua, ad esempio l'italiano. Vale la pena sottolineare che ci saranno sempre delle differenze nell'uso della lingua, ad esempio tra me e te, perché io sono stato educato in Germania e tu in Italia. Anche dopo quarant'anni di confronto con gli italiani ci sono sempre cose che non capisco. Tra gli italiani stessi ci sono delle differenze: due italiani nati entrambi a Milano si capiscono meglio di uno nato a Milano e uno a Roma perché hanno ricevuto lo stesso tipo di educazione. È difficile capirsi anche se si proviene da classi sociali diverse. Più l'educazione è simile e più è facile capirsi. Questo serve a spiegare come la comprensione non sia un meccanismo diretto, dagli stimoli di un cervello ad un altro. È il tuo cervello che ricostruisce gli stimoli percepiti e, parallelamente, ogni cervello ricostruisce più o meno allo stesso modo gli stimoli in quanto i meccanismi che compiono tale processo sono gli stessi.
Anche se si vive in stretto contatto per anni non si può mai essere certi di capire quello che succede nella mente altrui. Ad esempio mia zia diceva di mio zio, dopo che era morto, che era un uomo buono, ma in realtà era una sua costruzione, perché quello che succedeva nella sua mente non lo ha mai capito. Quindi si potrebbe sostenere che capirsi è una costruzione che due cervelli fanno in parallelo l'uno dell'altro senza però potersi concludere con una reale comprensione e compenetrazione reciproca. Ognuno vede il mondo secondo la sua esperienza e se le esperienze sono molto simili, allora due persone vedono il mondo in maniera quasi uguale, mentre, se le esperienze sono diverse il mondo è visto in maniera molto diversa. Uno che viene dalla classe operaia è difficile si capisca con uno che viene dalla classe capitalista e se lo fa è perché hanno un background di conoscenze/esperienze comuni.
- In questo mondo contemporaneo si parla molto di oggettività, ma alla luce di quello detto fin qui, come si risponde alla domanda: che cos'è la Verità?
Roth: Questa è una domanda che mi faccio sempre mentre compio le mie ricerche. Quando la concezione del mondo è abbastanza stabile, si crede, ad esempio, nelle verità della chiesa, nella parola del Papa, nelle affermazioni del governo, allora si può sviluppare un concetto di Verità. Credere in Dio, nel paradiso, nelle istituzioni in generale, permettere di credere in certe verità.
Il mondo però è in continuo cambiamento e non esiste verità. Ogni giorno ognuno di noi fa esperienze sempre nuove e diverse che rendono continuamente rinnovabili le nostre conoscenze.
Anche nella mia scienza (la neurobiologia) è così. Dieci anni fa, ad esempio, alcuni esperimenti portavano a credere ad una certa verità, che poi in base a nuovi esperimenti si è dimostrato essere falsa; in realtà tempo dopo ancora, si è tornati sostenere la prima interpretazione e a ritenere che quella fosse la verità e non l'altra. Ad esempio, per quanto riguarda l'intelligenza, in Inghilterra Cyril Burt aveva fatto esperimenti sui gemelli monozigoti scoprendo che il 50% dell'intelligenza deriva da caratteri ereditari. Questo non piaceva alla comunità degli psicologi del tempo, i quali erano felici della mancanza di dati a sostegno di questa tesi, tanto che anche il suo discepolo Hans Eysenck dovette negare la verità proposta del suo maestro. Sorprendentemente anni dopo si scoprì che aveva ragione proprio Burt!
Niente vieta comunque che in futuro si possa scoprire che in realtà si sbagliava veramente.
Ogni volta che apro una rivista scientifica, soprattutto, leggo che molte delle verità che possediamo e delle cose che pensiamo non sono più giustificate. Questa è un'esperienza molto comune tra gli scienziati nel mio campo; allora cosa sarebbe la verità? Attraverso quale processo potremmo trovare la verità? La stampa dice la “verità”, il papa dice la “verità”, ma se io pubblico un articolo scientifico non posso dire: questa è la verità. Posso solo portare degli esperimenti che non risultino stupidi e, se confrontati con gli studi sul cervello dell'esperienza neuroscientifica degli ultimi cento anni, risultino coerenti ed con risultati plausibili. La verità non esiste perché non c'è alcun modo per trovarla. Articoli possono smentire altri articoli; si può dimostrare che alcuni esperimenti sono stati eseguiti male e che quindi i risultati non sono attendibili, ma mai affermare che quella sia la Verità.
Ci sono delle verità logiche, ma quello che ci interessa sono le verità empiriche e queste possono
essere ricercate solo attraverso la plausibilità, la coerenza e la consistenza di dati.
- La verità è allora un processo in divenire che sempre si rinnova in base a nuovi dati?
Roth: no, non si può proprio parlare di verità. Un filosofo potrebbe, per assurdo, affermare di credere in Tommaso D'aquino e rifiutare le affermazioni della scienza dicendo che sono tutte sbagliate. Noi crediamo che la scienza incrementi incessantemente le nostre conoscenze ma non lo sappiamo con certezza. (Con tono ironico,ndr): Potrebbe essere un errore totale e potrebbe averavuto ragione Tommaso o Aristotele o Gesù.
Spesso i miei studenti mi chiedono: professor Roth, esiste una vita dopo la vita? Io rispondo: non lo so. Quello che posso dire è che non esiste nessuna evidenza dell'esistenza di una vita simile a quella di adesso dopo la morte. Se c'è una vita può essere solo totalmente diversa dall'esperienza cheviviamo in questa terra. Non possiamo saperlo. Ad esempio il dogma della verginità di Maria è un'affermazione empiricamente indimostrata; non si è mai verificato nessun caso di concepimento senza inseminazione. La chiesa nonostante questo continua a sostenere il dogma della verginità che si regge, comunque, su un errore di traduzione. Infatti nel testo originale si parla di “donna giovane” non di donna vergine. Nelle successive traduzione, dopo l'errore, è stata mantenuta questa traduzione. Ogni teologo sa di questo errore, anche il Papa, ma nonostante questo continuano a sostenere il dogma illogico della verginità. In ogni caso è una “verità”che non fa parte del mondo indagato dalle scienze naturali, cioè di questo mondo. Si potrebbe anche sviluppare un concetto di anima all'interno delle scienze naturali identificandola con la psiche, ma se si parla di anima immortale allora io mi domando quale sia l'evidenza empirica che permette di affermare tale “Verità”.
- Dopo la morte io so che fine fa il mio corpo, so come si evolvono i processi di decomposizione del corpo, ma non ho idea di cosa succeda alla mia psiche, ai miei pensieri ai miei ricordi, anzi questi, come entità fisiche non sono nemmeno mai esistite.
Roth: perché no? Certo che sono esistiti, sono stati prodotti dal cervello. Il pensiero è uno stato fisico. É un po' strano, ma le emozioni esistono fisicamente. Se tu studi sotto quali condizioni il cervello produce i pensieri puoi descrivere tali processi. Il pensiero, la mente sono entità fisiche.
Sembra strano ma non c'è dubbio di ciò. Lo testimonia il fatto che quando si pensa intensamente il nostro cervello consuma più energia, ossigeno e zucchero. I pensieri, la mente sono entità fisiche perché seguono le leggi della fisica e dell'evoluzione e se questa macchina, il cervello, sparisce allora anche la mente sparisce, nel senso di come noi la sentiamo. Da teologo si può credere che la mente sia qualcosa di diverso, ma da scienziato io posso domandare solamente quali sono le evidenze per sostenere tali affermazioni. Tutte le evidenze sono che quando muore il cervello muore anche la mente. Ciò si vede anche con il deperimento dell'organo cervello nella vecchiaia che corrisponde con un deperimento della mente, come nei casi di alzheimer e di demenza senile, ad esempio.
Se esistesse un'anima che sopravvive alla morte dovrebbe essere un'anima che nel nostro mondo empirico non esiste. Io da agnostico posso dire: non lo so. Come filosofo del costruttivismo io non posso dire: Dio non esiste. È vietato. Se si volesse dare di Dio una concezione empirica allora potrei dire che Dio non esiste in quanto non ci sono prove di tale entità, ma se tu mi dessi una concezione non empirica di Dio io potrei dire semplicemente: non lo so. Parlare di Dio equivale a dire che esiste un pianeta che ha tanti aspetti interessanti ma che non è percepibile. Dipende quindi dal concetto che si ha di Dio, se si vuole abbracciare un punto di vista costruttivo.
- Per concludere vorrei ritornare sul concetto del “parlare” come elaborazione interna al cervello, qual'è il sostrato che ci permette di elaborare un'interpretazione delle intenzioni del parlante?
Roth: Noi abbiamo una base genetica per capire la lingua umana. Questa capacità si sviluppa nell'emisfero sinistro del cervello. Se io incontro un uomo che parla una lingua straniera, anche se non capisco ciò che dice, capisco che è un uomo e che sta parlando una lingua umana perché questa possibilità di comprensione è geneticamente determinata. Se passo del tempo con lui, piano piano, capirò alcuni significati che attribuisce a determinati vocaboli fino ad arrivare alla comprensione del suo circolo linguistico, in un movimento quasi a spirale.
- La Realitaet invece è la realtà fisica?
Roth: no, questo non si può dire perché se diciamo che la realtà fisica è la vera realtà non ci rendiamo conto che anche la fisica sia una costruzione del nostro cervello. La vera realtà possiamo solo sperare che esista, perché altrimenti diventa difficile spiegare molte cose, ma è sicuramente inconoscibile. Noi non possiamo descrivere la realtà perché dobbiamo usare il nostro linguaggio che deriva dalla nostra mente e quindi dalla nostra Wirklichkeit (realtà fenomenica).
Ad esempio se diciamo che i colori non esistono realmente, dobbiamo chiederci cosa esista allora?
Le frequenze della luce, potremmo rispondere, ma luce e frequenze che cosa sono? Sono concetti fisici. Sono costruzioni. Possiamo scrivere una formula per descrivere l'andamento delle frequenze della luce, ma una formula è una costruzione esclusiva della mente. Non c'è nessun modo per descrivere la realtà indipendentemente dalla nostra esperienza. Anche se riduco la fisica alle formule matematiche queste formule devono essere apprese da una mente, richiede uno studio di molti anni. È una costruzione che io mi faccio, anche se credo che il mondo segua queste leggi naturali. Bisogna rendersi conto che anche il concetto di legge naturale è un concetto costruito.
Questa costruzione però, stiamo attenti, non è “invenzione”, perché nelle scienze naturali abbiamo sviluppato un metodo che massimizza la plausibilità delle affermazioni. Se uno dicesse di aver visto Gesù io gli chiederei come ha fatto a accorgersi che era proprio Gesù e se mi rispondesse che lo sentiva non potrei che chiedergli di darmi una prova evidente di quello che sostiene, prova che in scienza è necessaria per giustificare ogni affermazione. La scienza però non ha niente a che fare con la verità, bensì con gradi di plausibilità.
Nessun fisico che conosco direbbe che la descrizione del mondo della fisica è identica alla realtà.
Nessun fisico può spiegare il perché della causalità, nessun fisico può spiegare il perché della gravitazione. Come si può dire che la fisica è la realtà se la base della fisica non è nota. Nessuno sa se questo mondo è esteso, nessuno sa se la luce viaggia; non si capisce come la luce immateriale abbia una velocità, seppur grande; ci sono i paradossi di Einstein per cui la velocità della luce non è additiva. Probabilmente non esiste la velocità, soltanto quando noi misuriamo ci sembra che esista.
Nessuno può spiegare se la luce è corpuscolare o è un onda. Certi esperimenti presuppongono sia un'onda, altri che siano corpuscoli. Questa non è verità. Questa non è la realtà.
- Esiste soltanto il mondo delle persone: konsensuelle Bereichs...
Sì, certo. Il mondo consensuale ci dice che talvolta sono corpuscoli talvolta onde. A volte ci dice le
luce viaggia, che ha una velocità. Dall'altra parte ci sono i paradossi di Einstein, la meccanica
quantistica è piena di paradossi.
La realtà è piena di paradossi!
Roth: ritengo che non si possa fare una teoria della mente senza tutti i dati della neurobiologia, in quanto le speculazioni possono andare in qualsiasi direzione, ma spesso le verità sono controintuitive.
Le caratteristiche dell'avere un'esperienza personale, del modo in cui pensiamo e di come percepiamo il mondo, non sono identiche a quelle dei processi cerebrali che hanno luogo nel cervello. Noi non percepiremo mai i meccanismi di sincronizzazione o l'attività diffusa, la topologia, della corteccia perché la nostra esperienza personale è illusoria in questo senso. È parte del senso comune pensare che ci sia un'istanza che pensa, che ragiona, che ha una certa percezione, ma poi studiando il cervello ci si rende conto che queste attività sono tutte in parallelo e distribuite. L'attività neuronale ha una forma molto diverso rispetto all'attività cosciente delle sensazione che noi sperimentiamo, tale esperienza è infatti un'illusione creata dal nostro cervello.
- L'esistenza della mente come la conosciamo attraverso l'introspezione è dunque fallace. Ma allora perché parliamo di mente e non solo di processi neuronali quando cerchiamo di spiegare l'attività cosciente umana?
Roth: da una parte si può dimostrare che quando abbiamo certi pensieri, certi sentimenti, c'è sempre un relativo substrato neuronale nel cervello. È possibile che un certo pensiero sia rappresentato da diversi processi neurobiologici, ma c'è necessariamente un rapporto tra stato mentale e stato cerebrale. Se si studiasse per lungo tempo un cervello di un individuo, alla fine, si potrebbe indovinare quello che pensa e quello che vede. Se lo si facesse bene si noterebbe che per ogni sensazione, ogni pensiero, ogni percezione e ogni emozione esiste un determinato substrato neurobiologico definito. Quindi si potrebbe identificare l'attività neurobiologica con l'attività mentale. Dall'altra parte però dal solo studio del cervello e della sua attività non si può capire, dall'aspetto neurobiologico e dal comportamento delle cellule, il significato, il “ meaning” di tale attività, che può essere determinato solamente dopo esperimenti psicologici, per esempio chiedendo ad una persona cosa pensava o cosa provava durante gli esami neurobiologici.
Dalla sola attività della corteccia, non si può determinare ciò che quella attività significa, tale significato non è per niente evidente. Se invece si domanda al paziente: hai visto qualcosa? Ed egli risponde per esempio: “sì, una freccia rossa”, a quel punto registrando l'attività della corteccia si può affermare che quei determinati processi sono l'equivalente di “vedere una freccia rossa”, ma dall'attività neurobiologica soltanto non si può dedurre niente. Soprattutto si deve considerare che quello che è il substrato della coscienza e della percezione, nella mente, non è determinato soltanto dall'attività che si può misurare, è molto di più. Si possono misurare poche cose dell'attività delle sinapsi.
In realtà c'è molto di più. Quindi non si può sostenere che un pensiero non sia nient'altro che il “firing” di una certa popolazione neuronale, perché ciò non è vero; è molto più complicato e dobbiamo ammettere solamente che quando i neuroni interagiscono in un certo modo emerge la coscienza o un pensiero ed il rapporto è sempre di uno ad uno: uno stato mentale implica uno stato neuronale, ma non si può ridurre l'esperienza all'attività neurobiologica.
- Per quanto riguarda la coscienza lei dice che il cervello produce la coscienza e fornisce le prove delle basi neurofisiologiche di questa produzione. Si può dire che questo spieghi la coscienza?
Roth: In un certo senso sì. Nei miei ultimi libri ho riformulato il concetto di coscienza fino ad arrivare a considerare almeno dieci tipi diversi di coscienza e si può mostrare come tutte queste coscienze abbiano un sostrato definibile nel cervello. D'altra parte però si può anche spiegare perché abbiamo bisogno della coscienza. Per esempio senza la coscienza non sarebbe possibile rendersi conto di ciò che si vede e si legge. In oltre anche la verbalizzazione è basata sulla coscienza. Possiamo avere percezioni non coscienti ma non possiamo darne conto in un atto verbale. Non possiamo effettuare alcun “report”. Ogni atto verbale prevede coscienza. Essa è dunque una forma di “information porcessinig”. Si può perciò spiegare la funzione della coscienza nell'ambito delle leggi naturali e dell'information processing. Non c'è un aspetto mistico in essa, anche se nessuno può esattamente spiegare come funziona. Forse in futuro ciò potrà avvenire...
- Che rapporto esiste invece tra processi consci ed inconsci? Cosa possiamo conoscere della nostra mente e cosa ci rimane inaccessibile?
Roth: questo è un problema di sviluppo individuale. I centri che producono l'Es (i processi inconsci)
si sviluppano molto prima dei centri che producono la coscienza, i quali si basano sull'attività della corteccia. Tutto quello che un neonato percepisce è o inconscio o comunque non può essere ricordato, non può essere memorizzato a livello cosciente. Forse il neonato può sviluppare prima dei tre anni processi consci, ma non può ricordare tali processi, perché la memoria non è ancora completamente sviluppata.
In oltre l'attività dell'amigdala e del sistema limbico è inconscia. Questi sistemi, del resto, si sviluppano molto prima e poi dominano il nostro comportamento decisamente più che i processi consci, che si sviluppano più tardi e non hanno poi grande influsso sul nostro comportamento rispetto a quegli inconsci; infatti il 90 per cento di ciò che facciamo è basato su processi inconsci.
C'è anche un altro punto importante: molte cose che un tempo erano coscienti (erano state apprese attraverso processi consci) ora non lo sono più sono pre-coscienti, intuitive.
Il 70 percento dei processi mentali sono “fuori dalla corteccia”, inconsci, prodotti dal sistema limbico. In oltre nella memoria a lungo termine si trovano tracce delle cose che una volta abbiamo imparato coscientemente ma che ora sono “sommerse”, sono diventate intuitive, automatizzate.
Tutto ciò è importante poiché questi processi guidano il nostro comportamento senza che ce ne
rendiamo conto. Pochissima parte del nostro comportamento viene regolato dalla ragione cosciente, poco, pochissimo, l'un per cento.
Questa è perciò la relazione che esiste tra pre-cosciente, incosciente, intuitivo e la coscienza acuta: tre anni fa ero a Siena e ho fatto tante cose, ho parlato con alcune persone e ho visto determinate cose, queste esperienze però non sono più presenti in dettaglio. Solamente quando sono di nuovo a Siena questa memoria inconscia(delle esperienze già vissute) si riattiva, mi guida, anche se non mi posso rendere conto (non posso accedere in prima persona) che cosa sia che mi guida. Ero con il professor Nannini in un ristorante e ho mangiato qualcosa che mi ha fatto stare male, sono quasi morto. Adesso solo questo ricordo è presente coscientemente, tutto il resto (delle esperienze) mi guida ma non è presente coscientemente, almeno non in modalità attenzionale (non posso rendermi conto che tali esperienze mi guidano).
- Ultimamente stanno emergendo sempre più conoscenze sui processi del cervello. Molte scoperte portano ad ammettere che l'io non esista e che sia un'illusione, lei cosa ne pensa?
Roth: Sì, io ho molto lavorato, negli ultimi tempi, con psicologi dello sviluppo dell'infanzia e insieme abbiamo verificato come si possa dimostrare l'esistenza di diverse fasi dello sviluppo dell'io del bambino. Ad esempio una forma di io estremamente primitiva è quella che permette al bambino di riconoscere i propri bisogni. Sviluppatasi questa capacità si evolve l'io dell'identificazione di sérispetto alla madre, poi l'io come agente, cioè la padronanza dei propri movimenti; l'io sociale e l'io linguistico si sviluppano più lentamente. Si può dimostrare che l'evoluzione di queste forme di io parallela a quella del cervello.
L'io però è sempre un “label”, un attributo, non un meccanismo. Per esempio quando un bambino fa qualcosa e sente la madre dire frasi del tipo: “Tu sei stato bravo”. Prima deve imparare che quando la madre afferma: “io ti dico che tu...” si riferisce a se stessa, poi deve capire che il “tu” è lui stesso.
Questo avviene in un certo periodo dopo il quale il bambino capisce che il “tu” è lui e allora capisce (apprende il concetto) anche che tutto quello che è controllato dal suo corpo e dalla sua mente è il suo “Io”. In realtà però l'io non è una sostanza che controlla tutto, è un “label” un'istanza unificatrice.
Allora si può dire che da una parte l'io è un'illusione: l'illusione che l'io stia al di sopra di tutti gli
altri processi mentali e li controlli. Dall'altra parte però senza la costruzione dell'io gli uomini non
potrebbero agire. Per esempio pazienti che hanno perso l'istanza unificatrice dell'io non sono in
grado di agire nel mondo.
La mia posizione è che da una parte l'io è una costruzione del cervello che non esiste di per sé,
come sostanza, ma allo stesso tempo senza questo principio compositivo l'uomo non potrebbe agire.
Allo stesso modo nella società umana esistono delle costruzioni, come la dignità dell'uomo, che non hanno una realtà fisica, ma sono concetti molto importanti. Concetti illusori possono essere molto importanti, democrazia per esempio!
- Nel cervello si può riscontrare una regione che può essere considerata la sede dell'Io?
Roth: di io differenti! Esiste, per esempio, una regione della corteccia prefrontale chiamata pre- SMA (Supplementary Motor Area) che si attiva solamente quanto agiamo in conformità con la nostre motivazioni interne. Tale area si attiva solamente nel caso in cui sentiamo che la nostra azione è guidata da un bisogno spontaneo ed interno al corpo e non ci sono motivazioni imposte dall'ambiente esterno. Si deve notare che se in un paziente si stimola elettricamente questa regione egli inizia un'azione e afferma di averlo fatto per sua volontà. È evidente invece che è stata la stimolazione elettrica a determinare tale azione.
È molto complicato capire il circuito neuronale che determina i motivi che ci spingono, per esempio, ad alzare un braccio. O tali motivazioni vengono da fuori, come nel caso del comando: “alza il braccio”, o vengono da dall'interno del corpo. Solo quando mi rendo conto che tali motivazioni provengono dal mio corpo, da me stesso quindi, posso sviluppare il concetto di “io agente”. Mi rendo conto cioè che sono il fautore dei miei atti.
Questo è solo un esempio di come l'io emerga dal cervello, ma ci sono molti altri tipi di io: della percezione, del linguaggio e della memoria, per citarne alcuni, e tutti questi tipi di io, quando ne diventiamo coscienti, posseggono diverse localizzazioni nella corteccia. Si può dimostrare subito, ad esempio, come a causa di una lesione del cervello il senso dell'io come agentività possa scomparire mentre senza che ciò disturbi la percezione e la capacità intellettiva; pazienti con tale lesione hanno l'illusione che qualche forza esterna li guidi.
Un altro esempio può essere fornito studiando la capacità di riconoscersi allo specchio. Può succedere che alcuni pazienti si alzino la mattina e vedano nello specchio, al posto di loro stessi, una persona che non conoscono. Questo accade perché i centri parietali che sono addetti al riconoscimento del viso solo lesionati o distrutti e non si può riconoscere nessuno, nemmeno se stessi. Dall'altra parte, pur non riconoscendosi nello specchio, il resto del loro io è sano e quando fanno qualcosa affermano tranquillamente“sono io che lo faccio”, ma non riescono a riconoscersi nello specchio. Allora si può intuire come i diversi io siano distribuiti nella corteccia quando sono coscienti, altrimenti se ci fosse un solo centro dell'io ci sarebbe un tutto o nulla; o l'io c'è o l'io non c'è. Invece come ho mostrato può darsi che alcune forme di io sussistano anche se altre sono sparite, questo perché la loro distribuzione nella corteccia è altamente differenziata.
- Un altro annoso problema con il quale oggi le neuroscienze si confrontano è quello del libero arbitrio. È un problema ancora più grande di quello dell'Io perché tutte le persone si sentono libere...
Roth: Non tutte! Ci sono pazienti che affermano: “io non sono libero, una forza dentro di me mi
dice quello che devo fare, io non sono libero”. Si potrebbe anche citare chi soffre di impulsi ossessivi: egli è costretto a fare qualcosa, come lavarsi le mani ogni cinque minuti, lo deve fare!
Ne è obbligato a causa di una malattia che attacca i gangli basali. Il suo cervello lo obbliga ad agire senza che egli possa compiere una scelta libera.
Quando abbiamo molta sete, in ogni caso, dobbiamo bere, non siamo liberi, può succedere che si beva anche se l'acqua è sporca e non ci sentiamo liberi, siamo spinti da un bisogno molto forte.
Perciò possiamo dire che sentirsi liberi significa: non c'è una forza esterna o interna che ci comanda, che ci domina e l'assenza di queste due forze significa “essere liberi”. Queste sono le precondizioni, questo basta. Gli psicologi che studiano le condizioni nelle quali le persone dicono “io mi sento libero...a partecipare a questo convegno o a bere o a non bere un caffè, ecc.” assumono semplicemente che essi siano liberi se nessuno li costringe e potrebbero agire altrimenti. Se ad esempio ho davanti del tè e del caffè, la libera scelta, io scelgo il tè invece del caffè e mi sento libero. Se tu mi domandi chi ha deciso per il tè invece che per il caffè, io affermo:io! Sentirsi liberi basta per la gente. In realtà studiando il cervello umano si potrebbe determinare esattamente quali siamo i processi cerebrali che hanno spinto a prendere il tè invece del caffè. Si possono spiegare i motivi totalmente. Allora io mi sento libero quando ho una scelta, ma questa scelta è determinata dai miei geni, dall'esperienza infantile, dalle esperienze fino ad oggi e tutti questi motivi mi determinano in continuazione.
Se si studiano a livello neurologico e psicologico le persone che bevono indifferentemente caffè o
tè, non si potrà dire preventivamente se prenderanno uno o l'altro. Infatti quando i motivi per effettuare una scelta si equivalgono, non ne esistono di prevalenti, può darsi che per scegliere si sia costretti addirittura a ricorrere al dado, al caso. Questo significa che a volte i meccanismi del cervello non trovano una motivazione forte per una soluzione o per l'altra. Non sempre quindi il nostro cervello determina esattamente le nostre scelte.
Hume affermava: “siamo liberi, ci sentiamo liberi, quando abbiamo una scelta”.
Quando decidiamo qualcosa, questo evento è sempre determinato dalla nostra personalità. Bisogna rendersi conto che la possibilità di decidere, la possibilità kantiana di decidere senza pulsioni, è assurda, non esiste. Quando Kant scriveva parlava principalmente della moralità. La moralità è agire contro i propri interessi, contro le proprie motivazioni interne. Per esempio se vedo qualcosa di molto attraente e nessuno mi guarda potrei volerlo rubare, ma non lo faccio per senso morale.
Anche aiutare un amico, o la propria moglie non è morale, perché dettato dal sentimento. La moralità è la coscienza della moralità. La moralità ha ragione in se stessa diceva Kant, ma questo è assurdo!
La gente ruba quando le probabilità di non essere presa sono minime; poche persone lo fanno anche rischiando. La ragione, quindi, entra in gioco solamente per calcolare le probabilità di successo, l'essere morale invece deriva dall'educazione ricevuta. La moralità è basata sull'esperienza individuale e sociale. Io, per esempio, sono stato educato da mio padre e dalla mia famiglia a non rubare anche se nessuno se ne accorge. Perché diventi un sentimento morale, però, un precetto deve essere ripetuto molte volte. È educazione.
La libertà morale di Kant non esiste: la moralità è educazione.
Per esempio, se accade che ti facciano molto arrabbiare e tu non uccida chi ti ha offeso significa che hai imparato a controllare i tuoi impulsi, che quella è diventata la tua natura, oppure che il tuo cervello ti ha allertato che ti possano prendere e mettere in prigione. Se però perdi veramente il controllo e uccidi, in tribunale il giudice ti condanna: “tu avevi la possibilità di resistere alla tentazione, e non l'hai fatto, sei responsabile delle tue azioni” dirà. In realtà tu potresti sostenere che ciò non era sotto il tuo controllo. Non sei responsabile dei tuoi geni e della personalità che ti hanno portato a fare quel gesto. Questo è un grosso problema etico che non si può risolvere in quanto il nostro diritto penale è basato sull'idea della libera volontà, che non esiste. O tu resisti perché hai una certa educazione e certi geni o non resisti perché hai un'altra educazione.
Noi studiamo i giovani criminale e investighiamo i motivi per cui commettono dei reati e possiamo sostenere che il 20, 30 per cento del loro comportamento è influenzato dai geni e il resto dall'educazione, della famiglia in primis. Essi non sono mai liberi in quanto questo tipo di
determinazione avviene nei primi anni di vita, quando non siamo ancora coscienti a pieno. Poi ci
condiziona per tutta la vita.
Il settanta-ottanta per cento della nostra personalità si forma durante l'infanzia. Molti studi
dimostrano che nello sviluppo della personalità e del comportamento i geni hanno un'incidenza del 20/30 per cento; almeno 50 per cento viene dall'esperienza primaria, da neonato fino a tre anni, poi il restante 20 per cento è determinato dall'esperienza da adolescente e da adulto. Questo vale per tutti, per persone normali, ma anche per criminali e pazienti. Noi cresciamo con una personalità che si forma molto presto, di cui non abbiamo nessuna coscienza. Dobbiamo ammettere l'idea di essere controllati da forze che non riconosciamo. Ognuno ha la sua personalità, ma non abbiamo nessun idea da dove venga tale forma. Solo dopo uno studia approfondito di molti anni si può determinare se un tratto della personalità venga dai geni o dalla prima infanzia e così si può ricostruire l'intera personalità. Ed è quello che facciamo con i giovani criminali. Sono soprattutto tecniche psicologiche quelle che usiamo, anche studi del cervello, ma soprattutto tecniche psicologiche.
Facciamo interviste, facciamo indagini sulla famiglia. Assenza di padre, madre drogata, mancanza
di soldi, niente educazione, miseria. Da ciò si può capire come evolve la personalità di questi ragazzi, in modo quasi standard. Dire che avevano la libertà di non rubare non esiste.
- Concluso il tema del libero arbitrio, lasciandoci dietro molte domande aperte, come ogni dialogo deve fare, la vorrei interrogare su di un tema più metafisico, nel senso di riflessione sulla fisica, in questo caso sulla neurobiologia. Lei ci dice che il cervello “crea” la realtà, che ciò che percepiamo non è una semplice rappresentazione della realtà, ma una vera e propria costruzione “Bildung”. La realtà che il cervello crea è piena dei nostri ricordi, delle nostre emozioni; è un mondo fenomenico. Lei la chiama Wirklichkeit. Ce la può descrivere?
Roth: Questa è un'idea che è diventata molto comune nella neurobiologia di oggi, nessuno avrebbe qualche dubbio che è così.
Quando tu visiti un certo luogo per la prima volta tutto è nuovo, interessante. Quando ritorni nello stesso luogo una seconda o una terza volta tutto è interessante, ma non come la prima volta. Se vivi in un posto per dieci anni, poi, lo vedi completamente diverso dalla prima volta. Anche in amore è così. Tu ti innamori di una bellissima ragazza, poi se vivi con lei per dieci anni ti scordi di perché ti appariva così bella!
Quella dei sensi è sempre un'attività selettiva, ma noi vediamo il mondo sempre attraverso la nostra memoria. La memoria non riflette il mondo esterno. La stessa memoria a lungo termine riscrive sempre la nostra esperienza, ogni giorno. Essa non è una conoscenza statica, è un processo: se torni in un luogo dove sei già stato, questa percezione ti viene riformata in modo sempre diverso. Allora dobbiamo riconoscere che l'uomo vede il mondo più o meno identico, ma sempre in relazione ai dati forniti dalla memoria.
Il cervello vede quello che aspetta. All'inizio, appena nati, prima di nascere, in realtà, siamo come ciechi. Il cervello deve fare un'interpretazione di quello che vediamo una prima volta. Questo meccanismo di interpretazione che inizia con la nascita, prima della nascita e non termina che con la morte implica come suo costituente che ogni volta che si ha una nuova esperienza l'interpretazione viene attualizzata modificandone o rinforzandone certi aspetti. Ogni volta il cervello crea un nuovo mondo basato sulla nuova esperienza. È un processo totalmente interno. Se conosci una persona da dieci anni sai che non è identica a come l'hai conosciuta dieci anni prima perché nel frattempo hai vissuto un lungo periodo di tempo che ti ha riscritto tutte le esperienze che avevi memorizzato.
Il nostro grande cervello percepisce ciò che si aspetta. Noi vediamo ciò che aspettiamo basandoci sulla memoria. Spesso siamo consapevoli solo delle variazioni che un esperienza ci presenta rispetto alle caratteristiche registrate attraverso la memoria. Se questa differenza appare molto profonda il cervello riscrive e modifica il contenuto dell'esperienza, se altrimenti la differenza è minima il cervello vede ciò che si aspetta di vedere in base alle sue precedenti percezioni, e questo, a volte, è anche estremamente pericoloso. Una cosa molto comune deriva, ad esempio, dall'incontro con un amico che ha portato la barba per 10 anni e se la taglia. Quando lo vedi dopo il cambiamento o non percepisci alcuna modificazione o vedi qualcosa di vago che ti disturba, ma non riesci a capire cosa.
Non percepisci immediatamente che non ha più al barba perché il cervello ti fa percepire il mondo su per giù come se lo aspetta e ci vuole del tempo perché riscriva le nuove informazioni dando vita ad una nuova esperienza percettiva. Questo è molto pericoloso, come dicevo in precedenza, se stiamo guidando nel traffico su una strada che percorriamo costantemente da 10 anni. Può succedere di non accorgersi di eventuali nuovi cartelli che segnalano che quella strada è ora senso unico perché la nostra percezione è oscurata dall'abitudine, dalle nostre esperienze passate; è come essere ciechi!
Tutto questo avviene perché per il nostro cervello è molto pratico basare la percezione sulla memoria e riscrivere i dati in suo possesso solo in presenza di grandi differenze è un risparmio di energia!
- A questo punto devo chiederle quale sia l'illusione per cui si crede di essere in prima persona gli autore delle proprie scelte quando invece è un sistema complesso mente-cervello che ci rende ciò che siamo.
Roth: L'illusione è che ci sia un io che è padrone. Se uno accetta la propria personalità, il fatto che
si è sviluppata dai geni e dall'esperienza passata, allora si accetta il proprio essere. Allora può dire: “questo sono io”.
Io sono composto da un mosaico di tante cose. La possibilità di cambiare la propria personalità è
limitata in età adulta. Bisogna accettarsi. Siamo come siamo. Così sparisce anche l'ansia. Si deve semplicemente accettare quello che siamo. La personalità è controllata dall'inconscio, non solo freudiano. È controllata da tutto ciò di cui non ci rendiamo conto, come ad esempio le intuizioni, e dalle esperienze passate che non si ricordano coscientemente, ma alle quali si può accedere con la coscienza attraverso la memoria. Anche i pensieri sono guidati da componenti inconsci di cui non ci rendiamo conto. Ciò va accettato. Nonostante tutto esiste comunque la scelta! Solo che ogni scelta sta entro l'ambito della personalità. Per esempio, un amico ti propone di andare al cinema e tu accetti, poi ci pensi meglio e dici di no, ma non sai perché. Se finalmente viene fuori che non vuoi andare al cinema per la paura di essere circondato dalla gente, ad esempio, ne diventi consapevole, ma non sai comunque perché hai questa fobia. Nonostante la consapevolezza, rimangono celati i motivi profondi del perché le cose stanno in un certo modo e non in un altro. E questo accade spesso. Noi facciamo e diciamo delle cose di cui non sappiamo spiegare il perché. Se tu mi domandi perché vuoi restare a casa nonostante sia un film molto bello io invento qualcosa, ad esempio, che devo finire un compito, ma non è vero, in realtà, ho paura.
Spesso la gente dà spiegazioni molto complicate dei propri comportamenti perché nel profondo non sa perché agisce in quella determinata maniera e inventa, dando motivazioni superficiali. Mi accade spesso di verificare questo fatto quando parlo della mia professione con dirigenti dell'economia tedesca. Sovente tendono ad aver bisogno di esplicitare di essere in un determinato modo; hanno bisogno di riconoscersi ed affermarsi come ambiziosi e lavoratori. Potrebbe essere tutto falso, ma loro hanno bisogno di auto-rappresentarsi un quadro unitario della propria personalità. Solo se si accettano invece i fatti suddetti l'ansia di vivere sparisce; tu sei come sei.
- Il problema della personalità desta in me grande stupore. Ancora di più però c'è un punto della sua teoria che mi affascina e mi sconvolge. Esattamente quando lei dice che la differenza tra mente e cervello è una differenza all'interno del mondo fenomenico. (quindi una differenza apparente, non reale). Ci può spiegare meglio?
Roth: io da neurobiologo mi metto a spiegare come il cervello produce la mente: faccio esperimenti sul cervello. Quello che vedo dall'esperimento però è un cervello che il mio cervello ha creato. Lo vedo davanti a me, ma tu invece puoi mostrare, attraverso un altro esperimento che è la mia corteccia visiva che ha creato il cervello che sto osservando. Quello che faccio, la mia mano quando la vedo, è una costruzione del mio cervello. Tutto quello che vedo è una costruzione del mio cervello. Attraverso la fMRI posso vedere il mio cervello, ma in realtà non è il mio cervello, ma un cervello costruito dal mio cervello. Anche io sono un costrutto del mio cervello! Ogni mia esperienza è una costruzione del mio cervello. Il cervello che mi crea non esiste nella mia esperienza.
- Io: è incredibile!
Roth: Nessun neurologo avrebbe dubbio che è così. Io vedo la mia mano e domando al neurologo dove si forma l'immagine che vedo ed egli mi risponde: nel cervello. Io sento qualcosa e mi domando dove sta accadendo? Nel cervello, ovviamente! Allora la conclusione logica è che esiste un mondo esterno reale dove esistono uomini, dove esisto anche io, (un uomo chiamato con il mio nome ed un cervello): questa è la realtà (speriamo)!
Il mondo dove esisto io (come percezione di sé) è stato invece costruito da quell'uomo con quel cervello ed il mio nome, ma io non lo potrò mai vedere! Tutto quello che vedo e sento è una costruzione del cervello. Dobbiamo ammettere che c'è un mondo reale dove esistono gli uomini e gli animali con dei cervelli che costruiscono mondi attuali (fenomenici), ma per noi questo mondo attuale è il solo mondo che esiste, l'unico che possiamo conoscere e non possiamo vedere oltre.
Anche se studio il mio cervello non posso trascendere la realtà fenomenica perché ciò che vedo è costruito dal mio cervello. Io non posso oltrepassare questo mondo. Anche logicamente non è
possibile. In questo momento, mentre parliamo, due costruzioni parlano in una mente che porta il mio nome e quando tu ti percepisci discutere c'è una creatura con il tuo nome nella cui mente avviene la conversazione ed abbina ai nostri costrutti la parola Io e la parola Tu.
- Come è possibile che due costruzioni che stanno in due menti (la nostre) che sono individuali, separate, entrino in contatto. Come è possibile che si svolga una discussione tra noi se siamo ognuno nella mente dell'altro?
Roth: Nel mio libro "Bildung braucht Persönlichkeit" ho trattato questo problema di nuovo. Ancora una volta mi sono chiesto come, se ognuno è imprigionato dentro se stesso, sia possibile capirsi.
Capire l'altro è un risultato di un lungo processo. Noi ci capiamo perché siamo esseri umani. Questo significa che possiamo capire l'espressione del viso, i gesti, gli aspetti emozionali degli altri, ci sono cose che capiamo spontaneamente. C'è comprensione anche senza parole. Inoltre possiamo parlare la stessa lingua, ad esempio l'italiano. Vale la pena sottolineare che ci saranno sempre delle differenze nell'uso della lingua, ad esempio tra me e te, perché io sono stato educato in Germania e tu in Italia. Anche dopo quarant'anni di confronto con gli italiani ci sono sempre cose che non capisco. Tra gli italiani stessi ci sono delle differenze: due italiani nati entrambi a Milano si capiscono meglio di uno nato a Milano e uno a Roma perché hanno ricevuto lo stesso tipo di educazione. È difficile capirsi anche se si proviene da classi sociali diverse. Più l'educazione è simile e più è facile capirsi. Questo serve a spiegare come la comprensione non sia un meccanismo diretto, dagli stimoli di un cervello ad un altro. È il tuo cervello che ricostruisce gli stimoli percepiti e, parallelamente, ogni cervello ricostruisce più o meno allo stesso modo gli stimoli in quanto i meccanismi che compiono tale processo sono gli stessi.
Anche se si vive in stretto contatto per anni non si può mai essere certi di capire quello che succede nella mente altrui. Ad esempio mia zia diceva di mio zio, dopo che era morto, che era un uomo buono, ma in realtà era una sua costruzione, perché quello che succedeva nella sua mente non lo ha mai capito. Quindi si potrebbe sostenere che capirsi è una costruzione che due cervelli fanno in parallelo l'uno dell'altro senza però potersi concludere con una reale comprensione e compenetrazione reciproca. Ognuno vede il mondo secondo la sua esperienza e se le esperienze sono molto simili, allora due persone vedono il mondo in maniera quasi uguale, mentre, se le esperienze sono diverse il mondo è visto in maniera molto diversa. Uno che viene dalla classe operaia è difficile si capisca con uno che viene dalla classe capitalista e se lo fa è perché hanno un background di conoscenze/esperienze comuni.
- In questo mondo contemporaneo si parla molto di oggettività, ma alla luce di quello detto fin qui, come si risponde alla domanda: che cos'è la Verità?
Roth: Questa è una domanda che mi faccio sempre mentre compio le mie ricerche. Quando la concezione del mondo è abbastanza stabile, si crede, ad esempio, nelle verità della chiesa, nella parola del Papa, nelle affermazioni del governo, allora si può sviluppare un concetto di Verità. Credere in Dio, nel paradiso, nelle istituzioni in generale, permettere di credere in certe verità.
Il mondo però è in continuo cambiamento e non esiste verità. Ogni giorno ognuno di noi fa esperienze sempre nuove e diverse che rendono continuamente rinnovabili le nostre conoscenze.
Anche nella mia scienza (la neurobiologia) è così. Dieci anni fa, ad esempio, alcuni esperimenti portavano a credere ad una certa verità, che poi in base a nuovi esperimenti si è dimostrato essere falsa; in realtà tempo dopo ancora, si è tornati sostenere la prima interpretazione e a ritenere che quella fosse la verità e non l'altra. Ad esempio, per quanto riguarda l'intelligenza, in Inghilterra Cyril Burt aveva fatto esperimenti sui gemelli monozigoti scoprendo che il 50% dell'intelligenza deriva da caratteri ereditari. Questo non piaceva alla comunità degli psicologi del tempo, i quali erano felici della mancanza di dati a sostegno di questa tesi, tanto che anche il suo discepolo Hans Eysenck dovette negare la verità proposta del suo maestro. Sorprendentemente anni dopo si scoprì che aveva ragione proprio Burt!
Niente vieta comunque che in futuro si possa scoprire che in realtà si sbagliava veramente.
Ogni volta che apro una rivista scientifica, soprattutto, leggo che molte delle verità che possediamo e delle cose che pensiamo non sono più giustificate. Questa è un'esperienza molto comune tra gli scienziati nel mio campo; allora cosa sarebbe la verità? Attraverso quale processo potremmo trovare la verità? La stampa dice la “verità”, il papa dice la “verità”, ma se io pubblico un articolo scientifico non posso dire: questa è la verità. Posso solo portare degli esperimenti che non risultino stupidi e, se confrontati con gli studi sul cervello dell'esperienza neuroscientifica degli ultimi cento anni, risultino coerenti ed con risultati plausibili. La verità non esiste perché non c'è alcun modo per trovarla. Articoli possono smentire altri articoli; si può dimostrare che alcuni esperimenti sono stati eseguiti male e che quindi i risultati non sono attendibili, ma mai affermare che quella sia la Verità.
Ci sono delle verità logiche, ma quello che ci interessa sono le verità empiriche e queste possono
essere ricercate solo attraverso la plausibilità, la coerenza e la consistenza di dati.
- La verità è allora un processo in divenire che sempre si rinnova in base a nuovi dati?
Roth: no, non si può proprio parlare di verità. Un filosofo potrebbe, per assurdo, affermare di credere in Tommaso D'aquino e rifiutare le affermazioni della scienza dicendo che sono tutte sbagliate. Noi crediamo che la scienza incrementi incessantemente le nostre conoscenze ma non lo sappiamo con certezza. (Con tono ironico,ndr): Potrebbe essere un errore totale e potrebbe averavuto ragione Tommaso o Aristotele o Gesù.
Spesso i miei studenti mi chiedono: professor Roth, esiste una vita dopo la vita? Io rispondo: non lo so. Quello che posso dire è che non esiste nessuna evidenza dell'esistenza di una vita simile a quella di adesso dopo la morte. Se c'è una vita può essere solo totalmente diversa dall'esperienza cheviviamo in questa terra. Non possiamo saperlo. Ad esempio il dogma della verginità di Maria è un'affermazione empiricamente indimostrata; non si è mai verificato nessun caso di concepimento senza inseminazione. La chiesa nonostante questo continua a sostenere il dogma della verginità che si regge, comunque, su un errore di traduzione. Infatti nel testo originale si parla di “donna giovane” non di donna vergine. Nelle successive traduzione, dopo l'errore, è stata mantenuta questa traduzione. Ogni teologo sa di questo errore, anche il Papa, ma nonostante questo continuano a sostenere il dogma illogico della verginità. In ogni caso è una “verità”che non fa parte del mondo indagato dalle scienze naturali, cioè di questo mondo. Si potrebbe anche sviluppare un concetto di anima all'interno delle scienze naturali identificandola con la psiche, ma se si parla di anima immortale allora io mi domando quale sia l'evidenza empirica che permette di affermare tale “Verità”.
- Dopo la morte io so che fine fa il mio corpo, so come si evolvono i processi di decomposizione del corpo, ma non ho idea di cosa succeda alla mia psiche, ai miei pensieri ai miei ricordi, anzi questi, come entità fisiche non sono nemmeno mai esistite.
Roth: perché no? Certo che sono esistiti, sono stati prodotti dal cervello. Il pensiero è uno stato fisico. É un po' strano, ma le emozioni esistono fisicamente. Se tu studi sotto quali condizioni il cervello produce i pensieri puoi descrivere tali processi. Il pensiero, la mente sono entità fisiche.
Sembra strano ma non c'è dubbio di ciò. Lo testimonia il fatto che quando si pensa intensamente il nostro cervello consuma più energia, ossigeno e zucchero. I pensieri, la mente sono entità fisiche perché seguono le leggi della fisica e dell'evoluzione e se questa macchina, il cervello, sparisce allora anche la mente sparisce, nel senso di come noi la sentiamo. Da teologo si può credere che la mente sia qualcosa di diverso, ma da scienziato io posso domandare solamente quali sono le evidenze per sostenere tali affermazioni. Tutte le evidenze sono che quando muore il cervello muore anche la mente. Ciò si vede anche con il deperimento dell'organo cervello nella vecchiaia che corrisponde con un deperimento della mente, come nei casi di alzheimer e di demenza senile, ad esempio.
Se esistesse un'anima che sopravvive alla morte dovrebbe essere un'anima che nel nostro mondo empirico non esiste. Io da agnostico posso dire: non lo so. Come filosofo del costruttivismo io non posso dire: Dio non esiste. È vietato. Se si volesse dare di Dio una concezione empirica allora potrei dire che Dio non esiste in quanto non ci sono prove di tale entità, ma se tu mi dessi una concezione non empirica di Dio io potrei dire semplicemente: non lo so. Parlare di Dio equivale a dire che esiste un pianeta che ha tanti aspetti interessanti ma che non è percepibile. Dipende quindi dal concetto che si ha di Dio, se si vuole abbracciare un punto di vista costruttivo.
- Per concludere vorrei ritornare sul concetto del “parlare” come elaborazione interna al cervello, qual'è il sostrato che ci permette di elaborare un'interpretazione delle intenzioni del parlante?
Roth: Noi abbiamo una base genetica per capire la lingua umana. Questa capacità si sviluppa nell'emisfero sinistro del cervello. Se io incontro un uomo che parla una lingua straniera, anche se non capisco ciò che dice, capisco che è un uomo e che sta parlando una lingua umana perché questa possibilità di comprensione è geneticamente determinata. Se passo del tempo con lui, piano piano, capirò alcuni significati che attribuisce a determinati vocaboli fino ad arrivare alla comprensione del suo circolo linguistico, in un movimento quasi a spirale.
- La Realitaet invece è la realtà fisica?
Roth: no, questo non si può dire perché se diciamo che la realtà fisica è la vera realtà non ci rendiamo conto che anche la fisica sia una costruzione del nostro cervello. La vera realtà possiamo solo sperare che esista, perché altrimenti diventa difficile spiegare molte cose, ma è sicuramente inconoscibile. Noi non possiamo descrivere la realtà perché dobbiamo usare il nostro linguaggio che deriva dalla nostra mente e quindi dalla nostra Wirklichkeit (realtà fenomenica).
Ad esempio se diciamo che i colori non esistono realmente, dobbiamo chiederci cosa esista allora?
Le frequenze della luce, potremmo rispondere, ma luce e frequenze che cosa sono? Sono concetti fisici. Sono costruzioni. Possiamo scrivere una formula per descrivere l'andamento delle frequenze della luce, ma una formula è una costruzione esclusiva della mente. Non c'è nessun modo per descrivere la realtà indipendentemente dalla nostra esperienza. Anche se riduco la fisica alle formule matematiche queste formule devono essere apprese da una mente, richiede uno studio di molti anni. È una costruzione che io mi faccio, anche se credo che il mondo segua queste leggi naturali. Bisogna rendersi conto che anche il concetto di legge naturale è un concetto costruito.
Questa costruzione però, stiamo attenti, non è “invenzione”, perché nelle scienze naturali abbiamo sviluppato un metodo che massimizza la plausibilità delle affermazioni. Se uno dicesse di aver visto Gesù io gli chiederei come ha fatto a accorgersi che era proprio Gesù e se mi rispondesse che lo sentiva non potrei che chiedergli di darmi una prova evidente di quello che sostiene, prova che in scienza è necessaria per giustificare ogni affermazione. La scienza però non ha niente a che fare con la verità, bensì con gradi di plausibilità.
Nessun fisico che conosco direbbe che la descrizione del mondo della fisica è identica alla realtà.
Nessun fisico può spiegare il perché della causalità, nessun fisico può spiegare il perché della gravitazione. Come si può dire che la fisica è la realtà se la base della fisica non è nota. Nessuno sa se questo mondo è esteso, nessuno sa se la luce viaggia; non si capisce come la luce immateriale abbia una velocità, seppur grande; ci sono i paradossi di Einstein per cui la velocità della luce non è additiva. Probabilmente non esiste la velocità, soltanto quando noi misuriamo ci sembra che esista.
Nessuno può spiegare se la luce è corpuscolare o è un onda. Certi esperimenti presuppongono sia un'onda, altri che siano corpuscoli. Questa non è verità. Questa non è la realtà.
- Esiste soltanto il mondo delle persone: konsensuelle Bereichs...
Sì, certo. Il mondo consensuale ci dice che talvolta sono corpuscoli talvolta onde. A volte ci dice le
luce viaggia, che ha una velocità. Dall'altra parte ci sono i paradossi di Einstein, la meccanica
quantistica è piena di paradossi.
La realtà è piena di paradossi!

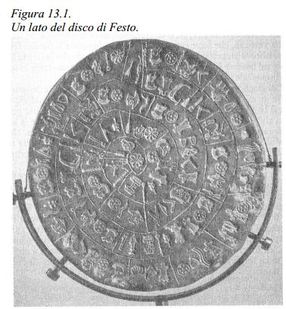
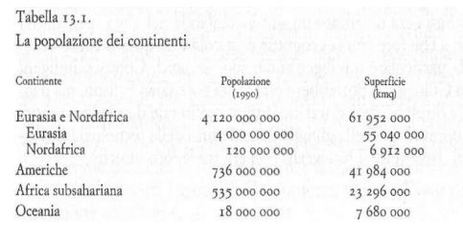
 Feed RSS
Feed RSS
